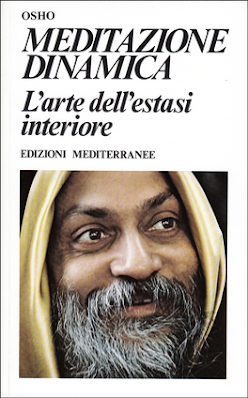Nonostante si sia prossimi a festeggiare il centenario del
Principio di Indeterminazione e di Incompletezza, rispettivamente dal
tedesco Werner Heisenberg, 1927, e dall’austriaco Kurt Gödel,
1930, la loro potenza rivoluzionaria nella concezione della natura e
della realtà non è stata sufficiente ad aggiornare l’assolutismo
razionalistico, materialistico ed economico delle culture del mondo.

Einstein, con Podolsky e Rosen, affermò che il senso comune –
ben codificato nella Meccanica classica – fa a pugni con la
conoscenza della materia/realtà affermata dalla Meccanica quantica.
Non riusciva a inscrivere nella sua Relatività ristretta quanto
affermato dalla cosiddetta interpretazione di Copenaghen,
nella quale si sostenevano per la prima volta il principio di
complementarità e quello di dualità. Il primo afferma
che a livello subatomico non è possibile conoscere
contemporaneamente posizione e velocità della particella; il
secondo, afferma la natura corpuscolare e ondulatoria delle
particelle elettromagnetiche. La nota lettera del 1935, detta EPR
come dalle loro iniziali, esordisce così: “La descrizione quantica
della realtà può essere considerata completa?
La perplessità di Einstein era del tutto plausibile, comprensibile e
condivisibile se osservata in termini empirici, sensoriali,
egocentrici. Che di una particella si potesse conoscere solo uno dei
due dati fondamentali della Meccanica classica, posizione e velocità,
non era accettabile. Che la materia potesse essere un’onda,
neppure.
La medesima perplessità si origina generando il proprio pensiero
filtrato dal dominio assolutistico del razionalismo. Da questo
discende l’idolatrata oggettività. Un plinto meccanicista
che prevede la realtà come oggetto disponibile ad essere posto sul
vetrino della conoscenza. Ma anche un cancello che impedisce di
accedere alla verità affermata tanto dal Principio di
indeterminazione di Heisenberg, quanto da quello di incompletezza
che emerge dall’indagine dell’aritmetica attuata dal
logico-matematico Kurt Gödel.
Se il principio del fisico tedesco – in collaborazione con Niels
Bohr – afferma che di una particella elementare è possibile
misurare solo la velocità o solo la posizione e che il comportamento
di questa è relativo all’osservatore, quello del matematico
austriaco osserva che entro la sintassi aritmetica si possono
verificare situazioni per le quali non è possibile affermare
univocamente siano vere o siano false, per le quali non si può altro
dire che non siano vere e non siano false.
Ma se nel loro ambito tecnico il valore di Werner Heisenberg e di
Kurt Gödel ha carattere dirompente rispetto allo stato della fisica
e della logica a loro precedente, per il resto del mondo è
altrettanto rivoluzionario per ragioni filosofiche, metafisiche,
esistenziali. La valenza filosofica implica che la descrizione
meccanicistica e logica della realtà, sulla quale abbiamo costruito
la cultura dominante, e abbiamo fatto coincidere con la verità
ultima – nonostante la scienza stessa sia la prima ad affermare la
provvisorietà dei suoi enunciati – era un abbaglio. Che non tutto
è misurabile dai rozzi strumenti dei tecnici; che c’è una realtà
impalpabile ben più potente e capace di quanto non possano le note
forze fisiche. La questione non riguarda infatti soltanto le
microparticelle per Heisenberg e alcuni estremi ambiti della logica
per Gödel, in quanto entrambi i Principi prendono massima forma nel
mondo sottile delle relazioni. La realtà dipende infatti dal
destinatario, è funzione del destinatario. E la relazione con il
destinatario modula la natura dell’emissione, modula la verità,
l’affermazione pronunciata dall’emittente. Ugualmente accade
nella relazione con se stessi, dove la realtà è modulata da valori
ed esigenze, tutte referenti di sentimenti ed emozioni.
Nella rete del Tutto – che partecipiamo a fare e modificare, e che
agisce su noi – tanto gli altri, quanto noi stessi, tendiamo a
modificare nel tempo la posizione originaria. Ciò che prima
stava in un modo, ora sta in un altro. Ciò che era
intollerabile lo è divenuto. Ciò che prima era corpuscolo ora è
onda. Ciò che credevamo vero, si mostra falso. Nella rete il tempo è
di tipo circolare e sussultoriamente stocastico. È burrasca e
bonaccia, buono e cattivo. Corrisponde a noi. I nostri sentimenti
sono il solo orologio per misurare il tempo. Quello dei ragionieri
della vita conta solo per i ragionieri della vita.
Perciò la questione perché onda o corpuscolo?, dilemma che
assilla solo gli scienziati classici, è poca cosa rispetto alla
verità dell’ontologico mutamento della realtà. Non solo. È
l’evidenza della contiguità, o meglio, dell’unità tra fisica e
metafisica. Rispettivamente espressione e matrice di una
realtà-trinità in quanto per esistere ha bisogno di noi. Così,
l’affermazione del mutamento in funzione dell’osservatore allude
alla sostituzione dell’ego con la relazione, della realtà
oggettiva con la realtà creata. È l’ultima spiaggia della laguna
del mondo, dove il razionalismo dei marosi arriva spento, senza più
forza per obbligarci a farci remare in un senso piuttosto che in un
altro, pur di far sopravvivere il dominio del nostro io e il mondo
che questo ci impone. Ma anche per evitare una patologica immobilità:
l’indecisione porta alla morte fisica e metafisica. È la
respirazione che, prima di altro, ce lo insegna.
Il mutamento come sola verità afferma che la descrizione del reale
che possiamo esprimere e sulla quale edifichiamo cultura, valori e
politica, è autoreferenziale, arbitraria, strumentale. In sostanza
truffaldina. È una descrizione che sussiste a causa della concezione
egocentrica della realtà, fisiologicamente inetta a riconoscere come
questa si avvalga di un autopoietico fermo immagine. Una costruzione
del tutto idonea ad affermare la logicità, l’oggettività, la
dignità e la legittimità del nostro pensiero. Un’istantanea
dell’essere che distorce il divenire secondo lenti d’interesse
personale.
La virtuale cornice di quell’immagine delinea un campo la cui
natura è bidimensionale, dove le nostre esigenze atrofizzano la
vitale e dinamica rete della realtà. È un campo in cui il tempo è
lineare e proteso all’infinito, lo spazio è de-finito dalla nostra
scientifica capacità d’indagine e noi non ne facciamo parte. Un
terreno in cui, come impavidi registi, distribuiamo canovacci e
tiriamo i fili secondo aulica logica, riconosciuta autorevolezza e
competenza specializzata.
Da Heinsenberg e da Gödel possiamo cogliere il necessario per
riconoscere i limiti di ciò che consideravamo definitivamente vero.
Dal grande oceano cosmico fisica quantica e logica approdano alla
medesima terra. Le osservazioni del matematico austriaco lo portano a
concludere che se il razionalismo ci induce ad argomenti utili per
sostenere la veridicità o meno di certe affermazioni, il principio
di incompletezza giunge ad affermare che non possiamo sostenere siano
definitivamente vere o definitivamente false nonostante la non
contraddittorietà degli assiomi d’origine.
La potenza del logos, in quanto creatore di realtà, se costretto
dalla logica aristotelica e dalla razionalistica, bidimensionale,
matrice del nostro pensare – al quale è da aggiungere l’invadente
principio moralistico della coerenza/senso di colpa quale virtù
assoluta, senza lato B – a dispetto dell’imperante scientismo,
non è sufficiente per comprimere la realtà – la cui natura è di
per sé infinta, cangiante e relazionale – entro le sue piccole
categorie, specializzazioni, classificazioni, distinzioni, giudizi.
La natura della realtà non è semplicemente più complessa della
nostra volontà di ordinarla, essa è inafferrabile, in particolar
modo quando si cerca di prenderla con attrezzatura inadatta.
Tanto nel principio di indeterminazione quanto in quello di
incompletezza troviamo dunque le verità prescientifiche, quelle del
mondo magico, del Tutto e dell’Uno, quelle della conoscenza già in
noi. È una conclusione accessibile ed accettabile soltanto a
condizione che le energie necessarie ad avvedersene non vadano più
ad alimentare la babelica impalcatura egoica con la quale crediamo di
raggiungere Dio, ovvero di poter conoscere la natura attraverso la
sua misurazione strumentale, attraverso la volontà egoica.
Liberati dall’io, i dilemmi e la ricerca della verità svaniscono.
L’interpretazione della storia, nella quale altro non vi è che
determinazione, suggestione, superstizione e inconsapevoli
congetture, da bidimensionale ritorna ad essere se stessa,
volumetrica: una dimensione nella quale ciò che l’io sostiene è
già accaduto ed è prevedibile, nella quale le babeliche verità e
analitici distinguo del tutto mostrano la loro architettura da
castelli di carta.
Dopo le tradizioni esoteriche, Heisenberg e Gödel rappresentano
l’approdo della ricerca occidentale e cosiddetta scientifica ai
lidi in cui tutte le tradizioni sapienziali della terra pazientemente
la attendevano per la cerimonia del Sé, la cui natura sta in
una riga.
Non più ripetizione ma creazione, non più sopraffazione ma
legittimazione, non più pena ma forza.
Per una
realtà nella relazione.
“Ma i concetti scientifici esistenti abbracciano sempre solo una
parte molto limitata della realtà, mentre l’altra parte, quella
tuttora incompresa, è infinita”.
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia.
“La scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la natura;
descrive la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per
interrogarla. È qualcosa, questo, cui Descartes poteva non aver
pensato, ma che rende impossibile una netta separazione tra il mondo
e l’Io”.
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia.
“[…] è nella teoria dei quanta che hanno avuto luogo i
cambiamenti più radicali riguardo al concetto di realtà. […] Ma
il mutamento del concetto di realtà che si manifesta nella teoria
dei quanta non è una semplice continuazione del passato; esso appare
come una vera rottura nella struttura della scienza moderna.
“La fisica classica partiva dalla convinzione – o si direbbe
meglio dall’illusione? – che noi potessimo descrivere il mondo, o
almeno delle parti di esso, senza alcun riferimento a noi stessi”.
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia.
“[…] han cominciato a spostarsi gli stessi fondamenti della
fisica […] il terreno stesso su cui poggiavamo. […] La progredita
tecnica sperimentale del nostro tempo porta nella prospettiva della
scienza nuovi aspetti della natura che non possono essere descritti
nei termini dei comuni concetti”.
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia.
“[…] il rigido determinismo della fisica newtoniana o classica è
stato colpito alla base. Nello stato d’un sistema fisico entra,
secondo Heisenberg, il concetto di probabilità, escluso
assolutamente, invece, non solo dalla fisica newtoniana ma anche da
quella di Einstein”.
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia (dall’introduzione di
Guido Gnoli)
“[…] nessun sistema rigorosamente definito di assiomi corretti
può comprendere tutta la matematica oggettiva, dal momento che la
proposizione che afferma la coerenza del sistema è vera ma non
dimostrabile nel sistema stesso”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“In corrispondenza con la formulazione in termini di dilemma del
teorema principale sull’incompletabilità della matematica, le
implicazioni filosofiche prima facie avranno anch’esse
l’aspetto di una disgiunzione; però ambedue le alternative sono
decisamente in contrasto con la filosofia materialistica”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“[…] la maggior parte dei matematici negarono che la matematica,
così come si era fino ad allora sviluppata, rappresentasse un
sistema di verità; piuttosto questo venne riconosciuto solo per una
parte della matematica […] e tutto il resto fu mantenuto nel caso
migliore in un senso ipotetico, secondo il quale la teoria affermava
propriamente soltanto che da certe ipotesi (da non giustificarsi) si
aveva diritto di trarre certe conclusioni”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“Infatti risulta chiaro che nello stabilire in modo sistematico gli
assiomi della matematica, divengano evidenti sempre nuovi assiomi che
non seguono logicamente da quelli stabiliti in precedenza”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“Ma la situazione cambia completamente se riguardiamo le proprietà
come generate dalle nostre definizioni”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“[…] una delle più sorprendenti e controintuitive tesi di Kant,
vale a dire la parte della sua dottrina del tempo […] [il tempo]
esiste solo in senso relativo. L’entità relativamente alla quale
esso esiste, secondo Kant, è il soggetto percipiente o, più
precisamente la sua ‘sensibilità’”.
Kurt Gödel, Scritti scelti.
“È probabilmente vero in linea di massima che della storia del
pensiero umano gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso ai
punti d’interferenza tra due diverse linee di pensiero. Queste
linee possono avere le loro radici in parti assolutamente diverse
della cultura umana, in tempi diversi e in ambienti culturali diversi
o di diverse tradizioni religiose; perciò, se esse realmente si
incontrano, cioè, se vengono a trovarsi in rapporti sufficientemente
stretti da dare origine a un’effettiva interazione, si può allora
sperare che possano seguire nuovi e interessanti sviluppi”.
Werner Heisenberg in Fritjof Capra, Il Tao della fisica.
“Ottant’anni dopo i lavori di Heisenberg e Schroedinger e
quarant’anni dopo la pubblicazione del libro di Capra [Il tao della
fisica, ndr], ben pochi scienziati hanno accettato intimamente e
completamente il fatto che le conseguenze filosofiche della fisica
quantistica, o il paradigma che ne consegue, coincidono praticamente
con la visione del mondo della filosofia buddhista (e di qualche
aspetto del pensiero indù e taoista). In fondo, molti ancora pensano
in modo semi-conscio che non è possibile che 2000 anni fa si
potessero avere concezioni considerate molto “moderne”. Non
riescono a liberarsi dal pregiudizio del progresso, cioè dall’idea
“ottocentesca” che l’umanità proceda in un’unica direzione,
verso conoscenze sempre maggiori e ‘più vere’”.
Guido dalla Casa, La fisica e l’Oriente, [articolo].
“Come scrisse Heisenberg: Ciò che osserviamo non è la natura
stessa, ma la natura sottoposta al nostro modello di indagine”.
Gary Zukav, La danza dei maestri Wu Li.
Lorenzo Merlo
Bibliografia
Albert Einstein, Relatività: esposizione divulgativa, Torino,
Boringhieri, 1967
Kurt Gödel, Scritti scelti, Torino, Bollati Boringhieri, 2011
Werner Heisenberg, Fisica e filosofia, Milano, Il Saggiatore,
1963
Gary Zukav, La danza dei maestri Wu Li, Milano, Corbaccio,
1995
Fritijof Capra, Il Tao della fisica, Milano, Adelphi, 1983
Guido Dalla Casa, La fisica e l’Oriente,
https://www.fisicaquantistica.it/scienza-di-confine/la-fisica-e-loriente
Einstein, Podolsky, Rosen, Lettera
EPR,
http://www.sciacchitano.it/Eziologia/Einstein%20Podolski%20Rosen.pdf